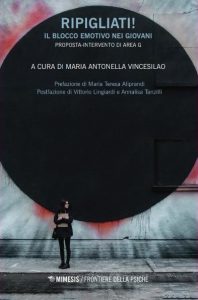Povere creature e psicoanalisi
Poor Things è un film del 2023 diretto da Yorgos Lanthimos, con attori del calibro di Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo; è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1992 scritto da Alasdair Gray.
Ambientato inizialmente in una Londra priva di colori dell’epoca vittoriana, racconta le vicende e le avventure di Bella, una giovane donna che, trovata in una condizione non ben definita di sospensione tra la vita e la morte, viene operata dal brillante e controverso Godwin Baxter. Questo chirurgo, il cui nome richiama un’entità creatrice, lavora servendosi di tecniche poco ortodosse che hanno un che di frankensteiniano, ma che danno la possibilità a Bella di restare/tornare nel mondo dei viventi. Inizia così per la giovane una seconda vita nella quale si trova ad affrontare in modo bizzarro, trovandosi lei in un corpo adulto, le tappe evolutive di ogni bambino che sono scandite nei vari capitoli della trama.
Sono molto interessanti i colori e le immagini che fanno da sfondo al racconto.
Nella prima parte del film, nella quale la protagonista inizia a conoscere il mondo come se per lei fosse la prima volta, le tonalità di grigio sembrano restituire all’osservatore l’esperienza del neonato che guarda il mondo circostante con delle “lenti” ancora embrionali, che si devono formare e sviluppare. La giovane gattona, emette le prime lallazioni, conosce la realtà circostante portandola alla bocca o servendosi di organi di
senso che nel loro stato ancora primordiale sono all’inizio del loro strutturarsi e definirsi. Ogden (1992), riprendendo Klein (1978), suggerisce che nel processo di sviluppo psicologico ci sia un movimento progressivo ma anche dialettico tra tre diverse modalità di esperire la realtà, vale a dire quella contiguo-autistica, quella schizoparanoide e quella depressiva.
Nella prima fase, quella tipica del neonato o di Bella, vale a dire la condizione di un neonato all’interno di un corpo adulto, la persona è concentrata su esperienze sensoriali immediate, non essendoci una distinzione tra sé e l’oggetto esterno. In quella schizoparanoide tale distinzione comincia ad emergere, sebbene caratterizzata da una visione dualistica che caratterizza la relazione con gli altri e il mondo esterno. Noi osserviamo la prima parte della pellicola, che ha tonalità in scala di grigi, come se stessimo osservando con gli occhi della Bella-neonata, occhi e filtri percettivi che sono in via di definizione. Il laboratorio di Godwin all’interno della sua casa e la casa stessa rappresentano l’utero materno e gli spazi di vita peri e neonatali. Bella si muove scoordinata, suscitando forse anche un senso di fastidio ed imbarazzo per lo spettatore nel vedere un figura adulta che non mostra la grazia e la compostezza che si addicono all’epoca vittoriana o al mondo dei grandi. Tra queste mura la giovane si sente contenuta, ricercando l’affetto genitoriale nella figura di Baxter. Questi però, all’interno della rappresentazione ancora scissionale del mondo della giovane, è oggetto di amore incondizionato o di odio senza freno. È l’oggetto buono quando è in grado di darle nutrimento e piacere, mentre diventa l’oggetto cattivo quando è fonte di frustrazione e dolore, non permettendole di esplorare gli spazi al di fuori delle mura domestiche.
Il mondo inizia a colorarsi, assumendo anche nel proseguire del film dei connotati fiabeschi che ci restituiscono il senso di meraviglia della scoperta
che fa un bambino, quando Baxter toglie il freno delle briglie che hanno i genitori preoccupati. Quando il desiderio di scoperta di Bella incontra la capacità negativa e di tolleranza all’incertezza del “padre” si aprono nuovi scenari. In termini bowlbyani potremmo dire che Baxter funziona come una base sicura che permette alla figlia a un certo punto di esplorare il mondo e di contare su di lui per fare dei “pit-stop” di rifornimento affettivo e di accudimento: questi a mio avviso sono rappresentati a un livello simbolico dalla possibilità di contatto tramite la corrispondenza epistolare e dal fatto che il chirurgo nasconda, cuciti all’interno di un abito della giovane, del denaro sul quale poter lei contare nei momenti di bisogno del suo peregrinare. È un gesto estremamente tenero e denso di significati e sembra comunicare “esplora il mondo e la sua bellezza e se hai bisogno, in ogni momento io
sono con te e sono a casa che ti aspetto”.
Iniziano così le esplorazioni e il peregrinare della protagonista. Nella prima parte, ambientata a Lisbona in compagnia di Duncan, Bella scopre il sesso ed altre esperienze di godimento immediato che spaziano dal cibo alla musica. Tuttavia la fase di disincanto sembra essere alle porte. Successivamente, infatti, ad Alessandria d’Egitto la giovane conosce con grande dolore il mondo nei suoi aspetti negativi: vede cosa significano la morte, la fame e la disparità sociale. Anche qui potrebbe aiutare la teoria kleiniana, in particolare il riferimento alla posizione schizoparanoide: emergono fantasie di persecuzione e l’ambivalenza nei confronti dell’oggetto che da fonte di piacere diventa repentinamente fonte di dolore. Con l’esperienza all’interno del bordello parigino, Bella si trova poi a fare quello scatto di maturità e consapevolezza che la porta ad una rielaborazione delle esperienze vissute e ad una loro integrazione. È qui che potremmo scorgere l’emergere della posizione depressiva di Melanie Klein e un suo articolarsi maggiormente quando la giovane torna a casa nella tenuta di Baxter. Troviamo qui la capacità di integrare, di tenere conto del punto di vista dell’altro, di riconoscere che l’oggetto esterno ha una propria realtà e di tenere insieme sentimenti contrastanti come, ad esempio, amore e odio. La protagonista torna alla tenuta di Baxter e si riappacifica con lui. Questo momento potrebbe indicare una maggiore comprensione della separazione e della perdita, perché la protagonista si confronta con il suo passato e accetta le conseguenze delle sue azioni.
Durante questo periodo, la protagonista sperimenta un senso di colpa per aver abbandonato Max, suo promesso sposo al momento della partenza per Lisbona, e per aver creato turbolenze nelle vite delle persone intorno a lei. Sono presenti sentimenti di tristezza e rimpianto per le scelte fatte, ma anche una crescente consapevolezza di sé e delle proprie responsabilità. Inoltre, la fase depressiva potrebbe essere evidenziata dalla ricerca di un
senso di appartenenza e di stabilità, come simboleggiato dal suo ritorno e dalla sua decisione di impegnarsi nella carriera medica accanto a Max. Questo potrebbe rappresentare quella ricerca di senso che può emergere solo dopo aver esplorato il mondo esterno e le proprie emozioni: qui troviamo una maggiore consapevolezza da parte di Bella delle sfide e dei conflitti emotivi che hanno fatto parte del suo viaggiare e del suo percorso di crescita, insieme a un desiderio di affrontarli e di trovare una nuova stabilità emotiva e relazionale.

Un articolo di Battaglini Alvise.