2013 – Il gusto della legalità
Percorsi internazionali. La legalità vista con gli occhi dei bambini da sotto e sopra l’equatore
Il volume Il gusto della legalità (realizzato nel 2013, con 2500 copie distribuite), accompagnato da una tavola di “cioccolato etico”, di qualità Caffarel.
Il libro: 140 pagine, corredate di disegni e illustrazioni, con parti in francese e malgascio; raccoglie la corrispondenza dei ragazzi delle scuole di Pino e di Jangany sul tema della legalità;
prefazione di Gian Carlo Caselli, Procuratore Capo della Repubblica a Torino.
Sono emerse riflessioni interessantissime davvero e con analogie inaspettate (mafia e briganti, uso delegittimato della Costituzione, corruzione…), ma anche divertenti episodi di vita quotidiana in cui “qualcosa non torna” nel rispetto dei diritti… e lo scontro diretto tra i ragazzi legato alle due culture storicamente così lontane.
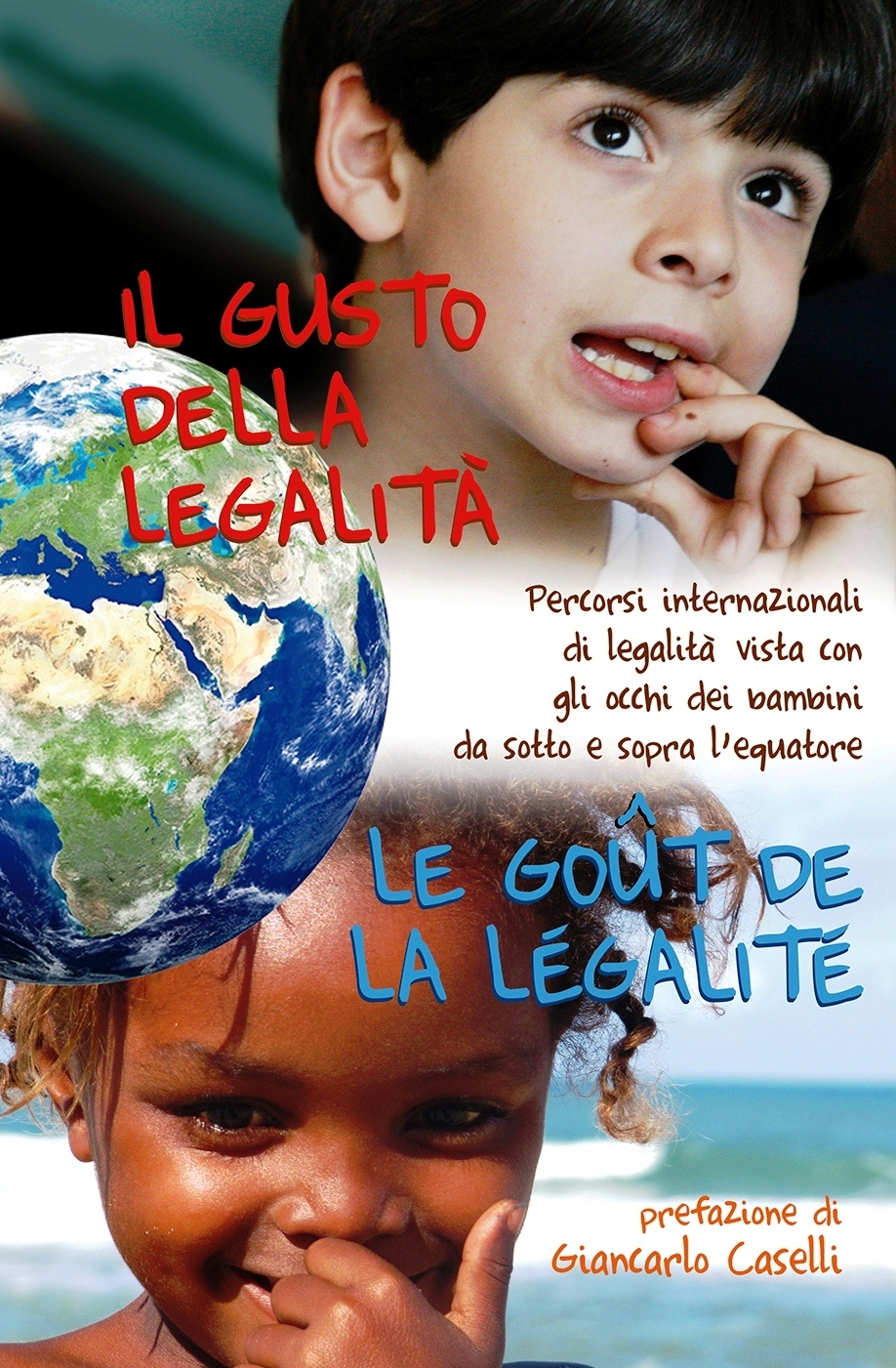
LA LEGALITA’ COME VALORE E L’ILLEGALITA’ COME FALSA SCORCIATOIA
La riflessione sulla legalità ha preso avvio nel modo più comune di sentire il tema – il rispetto delle regole, il timore della punizione – fino a svilupparne il suo senso più pieno, quello che la intende come responsabilità e un modo, una luce appunto, per vivere meglio, il sentire l’altro come un altro noi con cui condividere diritti; di qui la legalità al servizio della giustizia.
È stato spontaneo per i bambini e i ragazzi confrontare, in questo percorso, la loro condizione di vita e sentire in questa il desiderio di un’uguaglianza di diritti e di pari opportunità.
Non possiamo parlare di legalità senza porre prima la questione dell’uguaglianza: «è l’uguaglianza il fondamento della legge, non viceversa» (don Luigi Ciotti).
I giovani studenti si sono raccontati nelle vicissitudini quotidiane (di giustizia e ingiustizia, di rispetto o violazione delle regole, di necessità di attenzione all’altro e all’ambiente… ) ed è naturale che l’aggravamento della situazione di illegalità in tutto il Madagascar di questi anni si sia presentata puntualmente all’attenzione come una di queste vicissitudini.
Il confronto è stato frutto, in effetti, non tanto di una premessa teorica precisa, quanto di situazioni concrete intorno alle quali il tema della legalità si è dipanato nel sentire e agire degli studenti.
Di qui i racconti del venditore che non ha dato lo scontrino (“a me sembrava sbagliato”), del bullismo ai giardinetti (“io avrei chiamato un adulto, ma non c’era proprio nessuno; mia mamma era al bar”), vissuti con consapevolezza (“mi sembra ingiusto che debbano prendere in giro tutti per qualsiasi motivo e che giudicano le persone dall’aspetto fisico o per come vanno a scuola”) e con il desiderio di rispetto (“la giustizia permette anche alle persone più deboli di non essere maltrattate e rispettate”) perché tutti possono fare la propria parte (“perché la prepotenza del più forte non prevalga sul più debole, e nella nostra classe ci sarebbe da lavorare molto”).
I racconti di vita in classe ci hanno lasciato attraversare un po’ dei pensieri nascosti di questi ragazzi, con i maschi che a ruba-bandiera sono più veloci e “credono di far vincere la squadra però così facendo non passano la bandiera alle femmine”; episodi di isolamento (“quando un altro gli chiede se può giocare anche lui, a meno che non sia un loro amico, non lo fanno giocare”); di ingiustizia (“i maschi hanno avuto la palla la volta scorsa ed ora toccherebbe a noi la palla, ma non ce la vogliono dare e la tengono loro” e, alla mensa, “quando si da una porzione di pasta maggiore ad una bambina e una minore ad un’altra bambina. Che cos’hanno di diverso i due bambini?”), di qualche birbata che non rispetta le regole (“alcuni bambini senza farsi scoprire mettono la frutta marcia sotto i banchi degli altri”) con sentimenti di vergogna (“devo dire, con vergogna, che la nostra classe è piena di ingiustizie”), anche se talvolta sono episodi involontari (“tra compagni capita di trattarsi male e a volte non ce ne accorgiamo neanche”).
Culture e società lontane
Gli spunti però più interessanti sono nati proprio dal confronto delle situazioni di vita, appartenendo questi ragazzi a culture lontane e a realtà sociali profondamente diverse.
Lo dichiarano espressamente quelli in Italia: “questa cosa mi ha stupito molto: loro fanno tutto da soli, ad esempio cucinare, lavare”, “si costruiscono i giocattoli e stanno tutto il giorno da soli…”; “pensiamo che la vostra vita sia molto difficile e piena di disagi”; “ci sono molte differenze tra di noi, per esempio voi diventate autonomi già da bambini, noi intorno ai 14 anni. Riguardo alla alimentazione la vostra è più scarsa della nostra e il vostro pasto è più semplice del nostro”; “sappiamo bene che durante il periodo di piogge forti e cicloni soffrite molto. Sappiamo anche che molto spesso vengono i briganti che vi rubano il raccolto e gli animali”.
A questi i giovani di Jangany hanno risposto mettendo il luce una serenità che continua a sorprenderci, prevalendo sulla condizione di miseria: “È vero la nostra vita è più difficile ella vostra, ma anche noi abbiamo i nostri piccoli momenti di gioia e ringraziamo il buon Dio”.
Storie vere interrogano
Le tre storie da cui il percorso sulla legalità si è dipanato sono vicende realmente accadute.
Quella dei ragazzi malgasci Pasqualine ed Arnaud, “felicissimi di andare a scuola” dove apprendono le cose nuove e, grazie all’istruzione, hanno imparato a non farsi ingannare al mercato e a smascherare gli adulti bugiardi…
La storia di Annette, dieci anni, promessa sposa in cambio di cinque zebù, che non avrebbe potuto seguire il suo sogno di diventare medico nell’impossibilità di frequentare ancora la scuola. Una vicenda questa che in Italia ha suscitato una grande reazione emotiva, di ribellione: “Cos’è la legalità per voi? Per noi è prima di tutto: non si vendono le persone e non dovreste farlo neanche voi perché ognuno è libero di vivere la propria vita”.
“Non ci sembra giusto che voi dobbiate vivere con questa mancanza di legalità”. “Da noi, qui in Italia, ciascuno è libero di sposarsi con chi vuole, non per i soldi ma per amore”. “Trovo che una ragazza si debba sposare con chi vuole”.
Ribellione accompagnata però da un senso di dispiacere e di vicinanza sinceri: “Ce la fate a vivere con queste leggi? Come vi sentite?”.
I ragazzi di Jangany d’altra parte hanno puntualmente risposto: “È vero che abbiamo l’abitudine di sposare le figlie molto giovani (anche a nove-dieci anni). La nostra scuola ci insegna a cambiare poco a poco queste abitudini che non rispettano il diritto delle ragazze a studiare almeno fino a 16 anni” precisando però che “Noi non possiamo aspettare fino a 30 anni per sposarci perché la nostra vita dura solo fino a 35-37 anni”.
Spiegano da Jangany che “Ci sono molte regole della tribù e del villaggio che non sono scritte, ma che sono ben conosciute e rispettate dalle persone, perché c’è immediatamente una punizione per quelli che non rispettano queste regole. È l’intero villaggio, guidato dal lonala (la persona più anziana), che fissa la punizione”.
È con questa difficoltà che Annette riflette con gli amici su come superare le tradizioni che non lasciano crescere e capisce che “le donne non valgono meno degli uomini e che non è giusto obbedire ad una tradizione che considera le donne come degli oggetti da vendere o comprare”. Alla fine Annette studierà medicina e se vorrà sposarsi lo farà con una persona a cui vorrà bene.
Poi c’è la storia di corruzione, purtroppo recentemente frequente, dei gendarmi che fermano due ladruncoli mentre rubano pentole e stoviglie nella casa della povera Florette, ma poi li lasciano liberi in cambio di una gallina e di un’anatra. “Qualcuno dice che i ladri sono stati furbi, che i gendarmi hanno fatto bene”.
Sentimenti di timore
Qui, in Italia, una prima risposta è difensiva, rimarcando le differenze come per esorcizzare le paure: “Da noi quando i ladri vengono a rubare, intervengono subito i poliziotti nel giro di pochi minuti”… accompagnata da qualche precisazione sul livello di corruzione percepito: “La polizia, non essendo corrotta, indaga sul furto e quasi sempre riesce a smascherare i ladri”.
“Da noi in caso di pericolo e di salute ci soccorre l’ambulanza e in caso di ingiustizia ci soccorrono Polizia o Carabinieri”. “Da noi il cibo e l’acqua non mancano mai e quando ci ammaliamo abbiamo a disposizione dottori e medicine”.
Emerge serenità (“La legge in Italia è quasi sempre rispettata e la corruzione è rara” e “la Costituzione ci tutela. I nostri diritti vengono rispettati dalla maggior parte delle persone”) unita a timori (“però in Italia non tutti le rispettano e a volte non vengono beccati e continuano, tipo gli spacciatori di droga, i ladri, i truffatori…”).
Anche i ragazzi italiani hanno esperienza di furti, come la casa a socquadro (“avevano rubato l’oro e il cuscino di mio padre per metterci dentro la refurtiva e quindi siamo rimasti senza oro e mio padre senza cuscino”) e non manca la consepevolezza che problemi di diritto in Italia, perché legalità è giustizia, è rispetto di tutti “allo stesso modo, perché non è che se c’è un ricco bisogna trattarlo con tutti gli onori, invece se c’è un povero bisogna trattarlo meno bene”.
La questione della Costituzione
Il percorso pone quindi direttamente al centro la riflessione sulla correttezza e sul rispetto delle leggi. “A Jangany leggi come le nostre non esistono, le persone sono vendute in cambio di zebù, i ladri rubano e nessuno li punisce, non c’è l’obbligo di andare a scuola. Io ritengo fortunato ad essere nato in un paese come l’Italia, dove esistono le leggi che permettono di vivere tranquillamente dove le persone vivono al sicuro e nel rispetto reciproco”.
Al riguardo i ragazzi di Jangany condividono i pensieri sulla legalità e citano a loro volta la Costituzione spiegando che “è scritta, ma ogni dittatore la modifica come vuole” e che “la maggior parte delle persone non la conosce affatto, perché non sanno leggere né scrivere”.
Il problema del controllo e il parallelo briganti e mafia
A Jangany si affronta il problema delle forze dell’ordine (“Anche da noi ci sono le stazioni di polizia, ma il territorio è troppo vasto e non riescono a controllare le cose, perché non ci sono le strade”) e nasce un parallelo sulla criminalità organizzata: “Da noi non esistono le grandi organizzazioni criminali come la mafia, ma ci sono numerosi gruppi di briganti”.
Gli studenti in Italia invitano a non pensarsi soli nel combattere la delinquenza attraverso qualche slogan: “Mafia e briganti sono una forza troppo grande: contrastiamola! Se combattiamo tutti insieme la mafia verrà sconfitta. Colui che non rispetta gli altri rimarrà da solo! Perché se si è da soli non si arriva lontano”. “In Italia ci sono tante organizzazioni criminali, a Jangany ci sono tanti briganti. La legalità serve a combattere tutto questo”.
La povertà in Italia
La riflessione tra i banchi scolastici infine attraversa le situazioni di povertà in Italia, attraverso la lettura di giornali, con una conclusione amara : “Una notizia letta in classe su La Stampa dimostra che per i poveri non c’è legge”. I ragazzi non spiegano altrimenti la storia della signora che vive con quattro euro al mese di pensione, dorme con il riscaldamento al minimo, raccoglie la frutta scartata dai fruttivendoli al mercato… “Tre pagnotte di pane se li fa durare sei giorni perché al giorno ne mangia mezza” e quella della signora Egle che non aveva i soldi per mantenere la casa e per mangiare.
Più o meno, a grandi linee: l’emergere di qualche dubbio
Insomma i giudizi di rassicurazione sono oscillati con la consapevolezza che anche in Italia ci sia qualche difficoltà: “da noi ci sono delle ingiustizie sui disabili”; “nel nostro paese la legalità viene rispettata a grandi linee. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e voi?”; “anche da noi vengono i ladri e noi come voi non siamo affatto contenti” e ci sono “leggi che non vengono rispettate: ad esempio quando non ti danno lo scontrino o quando cercano di darti il resto falso”.
Per creare la legalità è essenziale la verità
«Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Non è stata casuale la scelta dei versi di Dante posti in apertura, curiosamente ambientati e pronunciati in una bolgia dell’inferno dove sono puniti i consiglieri di frode. Sono parole che mettono in luce lo stretto legame tra la conoscenza, quella che qui nasce tra i banchi di scuola, e il vivere non come bruti, ma ricercando una società virtuosa, dove l’io e il noi non siano contrapposti, la vita delle persone sia custodita e valorizzata.
Molti racconti ci hanno lasciato fortemente impressionati per crudezza e lettori accorti avranno colto le molte analogie tra la più raffinata società italiana e la più rozza situazione malgascia, senza cadere nell’illusione che due mondi così lontani presentino una sostanziale diversità nelle problematiche di giustizia e legalità.
Il linguaggio della legalità si impara attraverso quello dei rapporti umani, del rispetto dell’altro come un altro noi; così si impara a cogliere «la differenza –spiega ancora don Luigi Ciotti – tra una legge che promuove il bene comune e una che difende interessi e privilegi particolari».
Le regole funzionano quando incontrano coscienze critiche, responsabili, educate a distinguere e scegliere, non quando il rapporto con le regole è solo di adeguamento o dettato dalla paura.
Nello scambio di queste esperienze di vita si percepisce come non cambi la sostanza dell’agire umano: sulla via della costruzione del bene comune (“la legalità è alla base di un mondo giusto, dove tutti si devono impegnare per renderlo migliore”) oppure nella trappola delle scorciatoie dell’astuzia che persegue solo il proprio interesse. Non pensiamo affatto che la nostra sia una società dove tutto funziona, mentre a Jangany non è così.
Il percorso di istruzione che stiamo sostenendo, qui in Italia come a Jangany, è un percorso di costruzione del valore della giustizia, del bene comune e della cittadinanza responsabile: “La legalità non è solo il poliziotto o il carabiniere, ma anche e soprattutto fare il proprio dovere, rispettare le leggi, gli altri, tutto ciò che ci circonda”. «La mafia – diceva Caponnetto, ma potrebbe dirlo padre Tonino dei briganti nel Madagascar – teme più la scuola che la giustizia. L’istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa».
Stupisce la profondità e l’attualità di molte affermazioni: “Per creare la legalità è essenziale la verità”; “bisogna essere onesti per creare la legalità”; “le leggi si devono rispettare sia nel bene che nel male. In qualsiasi caso le leggi si rispettano sempre”…
Il mondo è vasto, attraversato da culture diverse e da qualcosa che tutti unisce: siamo della stessa umanità, con lo stesso bisogno di giustizia, di diritto di crescere con pari opportunità. “Un mondo giusto è un mondo bello, e ricordatelo sempre perché è una cosa importante: se tutti fanno la loro parte ci riusciremo insieme”.
La legalità è un bisogno umano
Ovunque si viva, in qualunque realtà sociale o di vita in comunità, le regole sono il punto di incontro dei bisogni delle persone e dal rispetto di esse discende lo star bene di quelle persone.
La legalità non ha altro scopo che generare e garantire lo star bene delle persone che in essa vivono insieme. In realtà, anche un uomo solo, per stare bene con se stesso e ciò che lo circonda, ha bisogno di regole. Rispettare le regole è innanzitutto rispettare se stessi e l’ambiente in cui ci si trova a vivere.
L’illegalità ha radici nella corruttibilità dell’uomo
Non c’è luogo dove la legalita’ non si sviluppi a causa delle condizioni, della realtà, dell’ambiente, della storia… L’illegalità ha radici ed espressioni nella debolezza e nella fragilità dell’essere umano, nella sua corruttibilità.
L’educazione, fondamentale per qualunque società
Quanto più l’essere umano si educa alle regole e al loro rispetto fin da quando è molto piccolo, tanto più la loro interiorizzazione è radicata e lo forma per la vita. La scuola è, dopo la famiglia, gli adulti di riferimento e talvolta anche in sostituzione di essi, il luogo dove l’individuo si forma e apprende le regole del vivere in comunità; per questo la sua esperienza e il buon funzionamento della scuola diventano fondamentali per qualunque società, in formazione o formata.
La legalità è per l’uomo l’espressione del suo essere dotato di volontà propria, del suo poter imprimere un cambiamento, del suo orientare la propria volontà, addirittura anche a suo danno: l’uomo ha la possibilità di farsi del male, di sbagliare, ma anche di scegliere di rispettare le regole, di sforzarsi continuamente di farlo e di trovare soluzioni in presenza di errori e trasgressioni.
gli amici di Jangany
